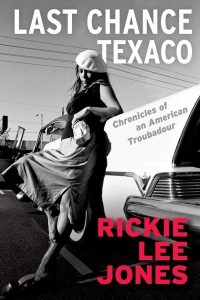Devo ammetterlo. Non ho niente dello spettatore televisivo. Anzi, come molti della mia generazione tengo il piccolo schermo in panchina in veste di sostituto occasionale. Scrivo questo pezzo spinto dalla visione di un altro episodio di “Che ci faccio qui”, programma in onda su Rai 3 condotto da Domenico Iannacone.
Devo ammetterlo. Non ho niente dello spettatore televisivo. Anzi, come molti della mia generazione tengo il piccolo schermo in panchina in veste di sostituto occasionale. Scrivo questo pezzo spinto dalla visione di un altro episodio di “Che ci faccio qui”, programma in onda su Rai 3 condotto da Domenico Iannacone.
Avevo già visto qualche puntata prima della quarantena e la cosa che ho notato fin da subito è che questa trasmissione sembra essere il richiamo dei disarmati, dei dimenticati, dei traditi, dei sognatori. In tv si celebra sempre chi ce l’ha fatta, poco chi ce la sta facendo. Anche la vita a volte è così: ci si aspetta all’arrivo. E questo il team di Iannacone lo sa bene, tanto che seguendo il programma si avverte tutto l’incanto presente nelle storie delle persone intervistate.
Ogni puntata è viaggio verso qualcosa, verso qualcuno. Forma e sostanza all’interno di una tv che disabitua al diverso, che troppo spesso contempla modelli privi di contatto col reale. Ebbene questa trasmissione, coraggiosamente, impone un cambio di frequenza. Qualcosa sta cambiando? Non lo so. So che sono stufo di guardare le stesse cose, gli stessi personaggi, le stesse canzoni da applaudire. Più che qualcosa di nuovo sono convinto serva un nuovo modo di guardare, o più semplicemente, serva tirare una boccata d’aria.
Definire un programma come questo risulta compito arduo: appena si cerca di rilevare qualche elemento familiare alla tv da noi conosciuta si fallisce miseramente. Domenico Iannacone è un giornalista, e da molisano vero si porta in spalla tutta la forza dei suoi silenzi: ascoltare chi ha qualcosa da dire diviene imperativo. Come diviene imperativo non giudicare e non cercare sempre un motivo per credersi più giusti attraverso l’ennesima domanda scontata. La sua sensibilità è palpabile, è una delicatezza che gli vedo prima nelle espressioni e poi nelle parole. È sorprendente constatare come Iannacone sia sempre mezzo tono indietro rispetto all’ospite: estrema, romantica, necessaria forma di rispetto.
C’è un preciso episodio su cui mi vorrei soffermare, forse la conferma che mi ha spinto a scrivere questo articolo. Il titolo è “Da casa tua a casa mia”, un viaggio di due puntate nel timido entroterra che collega l’Irpinia al Sannio. Iannacone e Franco Arminio, poeta paesologo, si immergono nell’esplorazione di questi territori in uno scenario reso ancora più spettrale dagli strascichi della pandemia. Il viaggio parte precisamente da Bisaccia, paese di residenza del poeta, fino ad arrivare a Torella del Sannio che ha dato i natali al giornalista. Bisaccia si porta dietro la ferita profonda del terremoto del 1980, da allora i suoi abitanti vanno via senza tornare ma c’è chi come Franco Arminio ha deciso di restare anche se tutto dice andare. La scelta di Arminio non è un semplice andare in controtendenza: sposare i paesi significa unirsi prima a sé stessi, poi agli altri. Il paese è un allevatore di demoni, fa rumore perché ti costringe ad ascoltarti.
Molti piccoli comuni italiani stanno scomparendo: si cresce in attesa della partenza, si sosta in attesa dell’occasione giusta per scomparire, lasciando spesso case vuote con appeso un cartello “vendesi” già destinato a invecchiare. La scelta di Arminio è un atto d’amore verso se stesso e verso le piccole comunità di tutta la Penisola, d’altronde dell’Italia “è bella la diversità”. Durante la trasmissione più volte mi sembra di ascoltare un visionario: il baratto, le poesie d’asporto, la Casa della paesologia… sono solo alcuni degli spunti che spingono a ripensare il modo in cui vediamo i paesi e soprattutto spingono a ricalcolare i toni della nostra esistenza. Idee tanto originali che sembrano custodire l’ambizione di una cura.
“Non ha senso dire che dei paesi si deve occupare solo chi li vive da dentro, magari bruciato dall’infiammazione della residenza. Non ha senso neppure pensare di guidarli da fuori senza coinvolgere le persone del posto. In questo caso non avremmo un paese ma outlet della ruralità. Per combattere lo spopolamento servono servizi e politiche di sviluppo locale ma serve anche la consapevolezza che un paese fa per natura resistenza al nuovo. Il paese tende a diffidare di chi ci sta dentro con la passione di cambiarlo. I paesani stanno uccidendo i paesi perché i paesani non sono più i cafoni di una volta, quelli potevano essere ostili al nuovo, ma almeno erano solidali con il luogo, avevano dei saperi, una dignità, una cultura antica. I paesani di oggi spesso sono inzuppati di sfiducia, sono rami senza radici, fringuelli dell’insolenza. Bisogna arieggiare i paesi portando gente nuova, il paese deve essere un intreccio di indigeni e forestieri. Bisogna agitare le acque, ci vuole una comunità ruscello più che una comunità pozzanghera”.
Il palleggio tra Iannacone e Arminio è una compagnia piacevole che conduce tra gli scenari di un’Italia la cui antica bellezza ha ceduto il passo ad un nuovo abbandono. Le comunità divengono pura scenografia, e la voce di Arminio risuona come un antidoto, un tentativo di restituire dignità a luoghi bellissimi rimasti fuori dal circuito turistico di massa. Il linguaggio utilizzato, la sua forma, divengono il messaggio stesso, e d’un tratto sembra sbiadire la forza degli assidui scoraggiatori che spesso militano nei paesi.
Sulla strada che porta a Torella del Sannio i due si fermano ad Altilia, sito antico romano dalla bellezza silenziosa. Benvenuti nel Sannio, un territorio talmente timido che fa fatica anche a promuoversi. I due viaggiatori dipingono l’affresco di un Molise silenzioso, dove si può vivere in pace con sé stessi, un museo del silenzio. Qui vanno via tutti, specialmente chi è rimasto; le parole dell’assenza sono sghembe e Domenico Iannacone, da cassa di risonanza degli ultimi diviene voce del vuoto.
A Torella Iannacone ha diversi affetti e una casa che ha chiamato “Dimora Itaca”.
Lui e Arminio si siedono sul divano, dinanzi a loro più che una finestra c’è un rettangolo di azzurro: “potresti dire, vado a Torella a vedere il cielo”.
Che ci faccio qui genera flebili domande nei sognatori e audaci risposte in chi ancora deve capire che per sognare non è necessario dormire. Catalogare questo tipo di spettacolo è impossibile: parlare delle periferie dell’esistenza è sempre stato visto come qualcosa di minore, roba da terza serata. Ma qui forma e contenuto esprimono una vocazione letteraria, una bellezza non firmata ma una bellezza umile. La stessa di chi, oltre se stesso, cerca un’umanità a cui appartenere.
Antonio Alberto Di Santo